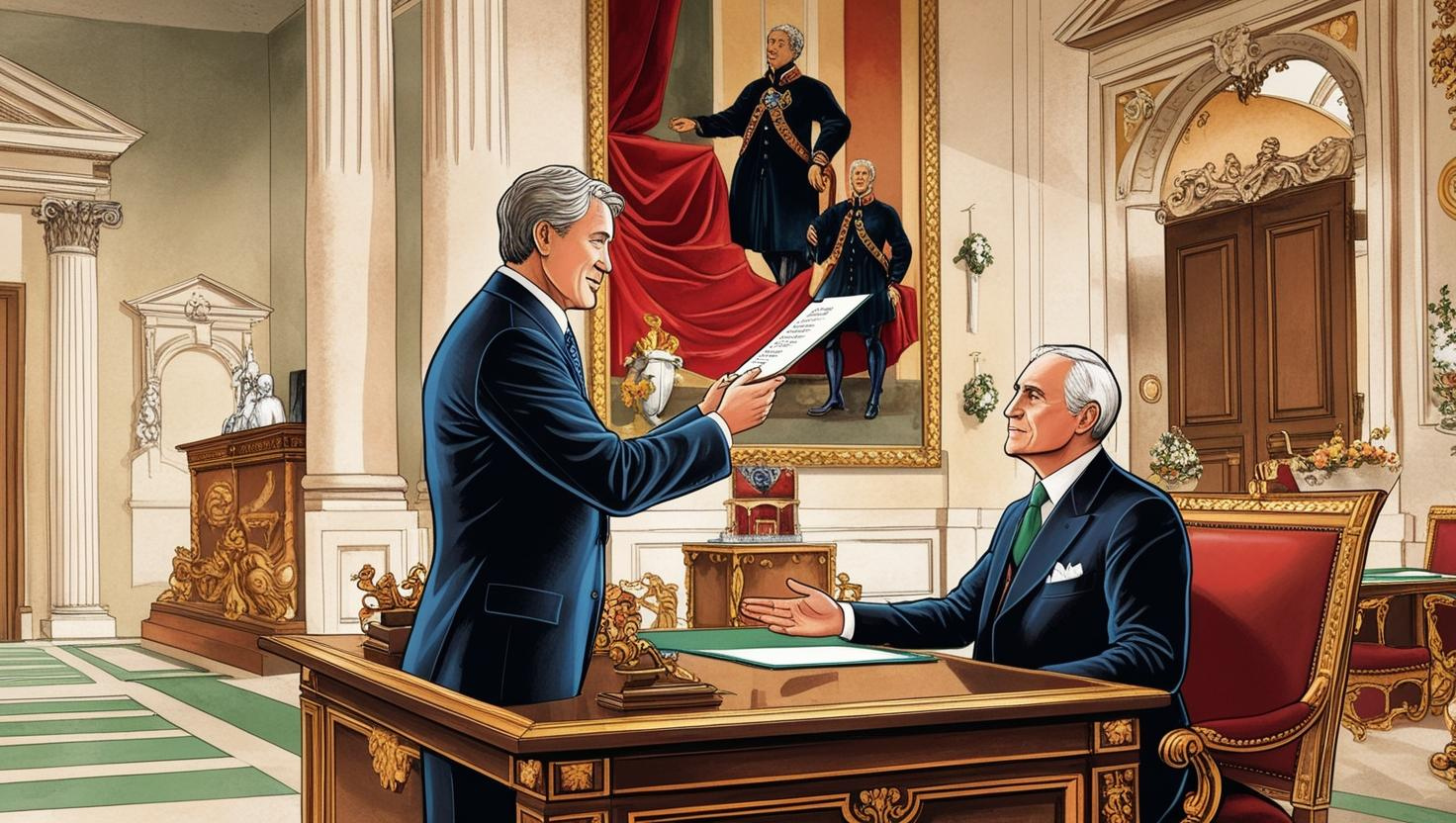PREMESSA CONCETTUALE
La giustizia amministrativa, intessuta di rigore procedurale e termini decadenziali, coltiva un rimedio alternativo assai noto, sovente utilizzato per rimediare ai rigori decadenziali del tempo e, dunque, alla inammissibilità del giudizio. Si tratta del ricorso straordinario al Capo dello Stato, un istituto che, per un verso, celebra la terzietà del Presidente della Repubblica, sospinta sino al potere di rendere giustizia alla stregua di un organo giurisdizionale, per altro verso concede riparo allo spirare del termine di impugnazione giurisdizionale, fissato, di norma, in sessanta giorni.
Ed invero, munito di un termine dilatato di 120 giorni, il ricorso straordinario costituisce una sorta di salvacondotto suppletivo rispetto al prolungarsi dell’inerzia dell’avente interesse ed assicura, altresì, un pronunciamento avente attitudine, alla stregua di una sentenza, a dirimere la controversia secundum legem ed a costituire titolo esecutivo e strumento di ottemperanza coattiva.
A fronte di tutto questo, appare evidente l’ambiguità sistematica dell’istituto che, fortificato da una modalità paragiurisdizionale e da un esito sostanzialmente giurisdizionale, è esposto ad inevitabili momenti di collisione con l’universo giurisdizionale propriamente detto, soprattutto allorchè provvedimenti connessi vengano separatamente giustiziati presso ciascuno dei predetti momenti decisori.
Con l’odierno lavoro si proverà a puntualizzare le ambiguità ed i limiti che si connettono alla contemporanea esistenza dei due giudizi amministrativi ed a ricercare, nell’interesse superiore della giustizia, le più utili soluzioni.
II – Il ricorso straordinario, un’anima giurisdizionale in un corpo amministrativo
Il ricorso straordinario, ancorchè finalizzato a partecipare del complesso universo del decidere amministrativo, non trova collocazione all’interno del codice del processo amministrativo, il dlgs 104/2010. Esso, al contrario, viene ospitato all’interno del DPR 24.11.1971 n. 1199, dedicato, espressamente, ai ricorsi amministrativi. Dunque, nonostante la sua sostanza giurisdizionale, il ricorso straordinario non sfugge alla sua matrice amministrativa, come la “sedes materiae” suggerisce.
Nel dettaglio, il ricorso straordinario trova posto nell’ambito del Capo di chiusura del DPR 1199/1971, il n. III, che segue il capo I (ricorso gerarchico) ed il capo II (ricorso in opposizione). Sul piano storico-sistematico, si ricorda che l’articolato ebbe una funzione attuativa del disegno costituzionale, che imponeva un sindacato integrale all’azione pubblica, sia per via amministrativa che per via giurisdizionale, correlandosi così alla coeva istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, adottata con D.P.R. 6.12.1970 n. 1034. Sul punto, si annota che l’art. 97 della Costituzione chiama la pubblica amministrazione, con modalità perentorie ed inderogabili, a coltivare l’imparzialità, l’efficienza ed il principio di legalità, implicitamente schiudendo a meccanismi di autocontrollo amministrativo e con salvezza, secondo gli artt. 24 e 113 della Costituzione, della giustiziabilità di tutti i diritti ed interessi legittimi.
In altri termini, il combinato disposto tra DPR 1034/70 e DPR 1199/71 ha reso effettivo il riordino perseguito dalla Carta Costituzionale a proposito delle relazioni correnti tra P.A. e cittadino, sciogliendo il nodo della legittimità ‘a divinis’ dell’azione amministrativa ed imponendo, al contrario, un severo controllo di legittimità e di merito sull’operato degli apparati pubblici.
In questo quadro, il capo III del DPR 1199/1971 completa il disegno istituzionale, apprestando un rimedio ulteriore, collocato in una via mediana tra quello giurisdizionale e quello amministrativo, con coinvolgimento solenne del Capo al Capo Stato, quale garante della terzietà del giudizio.
III – Il contenuto del Capo III del DPR 1199/1971 – Il fenomeno della trasposizione del ricorso straordinario nel giudizio ordinario
Il Capo III del DPR 1199/71 esordisce con l’art. 8, annotando che “Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.
La norma risente, dal punto di vista semantico, di certa vetustà della dottrina del tempo che assegnava l’aggettivo ‘definitivo’ ai soli atti scrutinati in sede di ricorso gerarchico o di opposizione. Ebbene, tale discrimine ha perso di senso, giacchè tutti gli atti amministrativi, aventi attitudine ad incidere direttamente o indirettamente su diritti ed interessi legittimi, sono liberamente giustiziabili. Ne segue che, in presenza di atti effettivamente lesivi, è sempre ammissibile il gravame straordinario, secondo un modulo che è analogo al ricorso giurisdizionale innanzi al Giudice Amministrativo.
Il secondo comma introduce, invece, al cuore del problema ed affronta, con chiarezza testuale, il tema della relazione corrente tra giudizio amministrativo e ricorso straordinario. In esso si coglie la natura alternativa dei due rimedi, congegnata con tale intensità da determinare, inevitabilmente, l’inammissibilità del secondo giudizio nella giacenza del primo. Precisa infatti la norma che, Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.
Dunque, in linea con l’invalso principio electa una via non datur recursus ad alteram, la scelta tra il rimedio giurisdizionale e quello straordinario è secca e dirimente e non consente, allorchè si tratti del medesimo atto, ritorni o travasi dell’uno nell’altro.
***
La separazione tecnica tra i due giudizi trova, tuttavia, un’eccezione tipizzata dall’art. 10 del DPR 1199/1971. E’ infatti previsto che le parti controinteressate, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notificazione, possano richiedere la trasposizione del ricorso straordinario in ricorso giurisdizionale, evidentemente preferendone la maggiore ampiezza istruttoria e partecipativa. Più precisamente, la norma dispone che I controinteressati (a seguito di sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 148/1982 anche gli enti pubblici diversi dallo Stato), entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all’organo che ha emanato l’atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all’organo che ha emanato l’atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
Dunque, a scelta dei controinteressati e dalle pubbliche amministrazioni ammesse, è dato mutare il rito straordinario, di natura paragiurisdizionale, in rito ordinario, di stretta osservanza giurisdizionale. Ciò attraverso un canale tipico – e, dunque, tassativo – spettante esclusivamente alle parti officiate, titolari dunque di un titolo potestativo, cui gli organi officiati non hanno modo di sottrarsi ed al quale nessuna delle controparti può legittimamente opporsi.
In mancanza di tale opzione, l’ultimo comma dell’art. 10 dispone che si “preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l’impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo”. Anche questa norma di chiusura appare obsoleta, giacchè a nessuna delle parti è dato impugnare l’esito del ricorso straordinario dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Ciò evidentemente, ad evitare una inammissibile duplicazione di giudizio presso il medesimo organo supremo di giustizia amministrativa, autore del parere fondativo della decisione del Capo dello Stato.
IV – Il procedimento e l’istruttoria del giudizio straordinario. La funzione giurisdizionale assegnata. La remissione all’Adunanza Generale ed alla Corte Costituzionale.
Sul piano procedurale, gli artt. 11 e 12 del DPR 1199/1971 dispongono che il ricorso straordinario, a certificarne una funzione decisoria di livello apicale, venga trasmesso alla sezione consultiva del Consiglio di Stato, per l’espressione del relativo parere sul quale fondare la decisione finale. Vi è in questo passaggio un preciso tratto giurisdizionale e nomofilattico, atteso che lo stesso art. 12 dispone che, ove si tratti di questioni di massima rilevanza o sulle quali si colgano momenti di contrasto giurisdizionale, le stesse possano esse rimesse all’Adunanza Generale del Consiglio di Stato allo scopo di assicurare unità e coerenza decisoria alla giustizia amministrativa.
E’ evidente che l’investitura del Consiglio di Stato, chiamato ad una “plena cognitio” e, addirittura, facultato ad investire delle questioni l’Adunanza Generale, sottrae il ricorso straordinario alla sua “sedes materiae” amministrativa, proiettandolo verso la differente e tipica dimensione della giurisdizione.
Ma v’è di più. L’art. 12 pone un ulteriore tassello giurisdizionale, nella parte in cui stabilisce che, ove la decisione del ricorso dipenda dalla risoluzione di una questione di rilievo costituzionale, la sezione del Consiglio di Stato possa sospendere il procedimento consultivo e, “riferendo i termini ed i motivi della questione, ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87, nonché a notifica del provvedimento ai controinteressati”.
Dunque, la sezione del Consiglio di Stato sedente in sede di ricorso straordinario è, a tutti gli effetti, giudice “a quo” ai fini dell’attivazione del procedimento incidentale di costituzionalità, alla esatta stregua di un organo della giurisdizione ordinaria. Il che adombra, ancora di più, una omologia di poteri e funzioni, tale da rendere non scrutinabile una distinzione funzionale e di scopi tra i due rimedi. Ciò si evince chiaramente dall’ultimo comma dell’art. 12 che assegna al parere del Consiglio di Stato una funzione giurisdizionale piena e statuisce possa disporre:
a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell’assegnazione di un breve termine per presentare all’organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;
b) per l’assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
d) per accoglimento e la rimessione degli atti allo organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;
e) per l’accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.
Una cognizione piena, dunque, assimilabile a quella nella disponibilità del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 34 c.p.a., fatte salve, tuttavia, le questioni risarcitorie, sottratte allo scrutinio del Capo dello Stato.
Riguardo a tale ultima questione, si è posto, in effetti, il tema della latitudine del potere decisorio del Giudice Straordinario. Ebbene, sulla base del criterio di effettività della tutela (art. 1 dlgs 104/2010), è stato ritenuto ammissibile proporre innanzi al Capo dello Stato azioni diverse da quelle di mero annullamento (es., le azioni di adempimento ex art. 34 comma 1 lett. c. c.p.a.), aventi ad oggetto la condanna della pubblica amministrazione all’emanazione di un provvedimento o, comunque, ad un facere. Si è escluso, invece, che possa darsi luogo ad una domanda risarcitoria (Parere Cons. St., sez. II, 11 giugno 2018, n. 1517), in quanto presupponente un potere di scrutinio istruttorio (ad esempio audizione testi) che il rito straordinario non consente.
V – Natura ed effetti della decisione del Capo dello Stato
Sul piano formale, l’art. 13 dispone che La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente. Trattasi, all’evidenza, di un atto formalmente presidenziale ma, sostanzialmente, riferibile al Consiglio di Stato, titolare di un parere che è, insieme, obbligatorio e vincolante (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 23464 del 19 dicembre 2012). Unico limite, che formalmente distanzierebbe la decisione dalla terzietà assoluta che permea il procedimento giurisdizionale, è la conservazione in capo al Ministero competente di un potere di “proposta”. Ebbene, detta proposta è priva di valore sostanziale ed è affatto impegnativa per il ricevente. Si ricorda che la proposta del Ministero è atto dovuto ed assume come suo contenuto indefettibile e pedissequo il parere del Consiglio di Stato. Così che essa non ha i tratti dell’autodichìa, ma della mera ostensione di una sostanza aliunde coltivata ed assunta.
***
Tale riflessione consente di intendere il senso e la portata della decisione di cui all’art. 14 dpr 1199/71, che risulta essere definitiva ed insindacabile. Come riferisce la giurisprudenza, la decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, definitivamente adottata ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 1199/1971, è irrevocabile ed immodificabile, oltre che insindacabile da parte di ogni altra autorità amministrativa e giurisdizionale (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4801 del 3 agosto 2018).
In altri termini, con l’emanazione del Decreto Presidenziale, il procedimento ha definizione e, alla stregua di una sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, completa il percorso della giustizia amministrativa consegnandosi, così, alla fase esecutiva.
VI – La decisione del Capo dello Stato, giudizio di ottemperanza e procedimento di revocazione.
Da tutto quanto sopra risulta che la decisione del ricorso straordinario, per quanto incardinata all’interno di un sistema amministrativo, assume l’efficacia e la forza di una res judicata. Ciò che autorizza di considerarla titolo esecutivo, utile ad accedere ai presidi dell’ ottemperanza, ai sensi degli artt. 112-113 c.p.a.
Il tema, in realtà, è affatto scontato. Ed invero, nel silenzio della legge, si è dovuta attendere l’elaborazione giurisprudenziale prima di ottenere la validazione del principio. Ed invero, così la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n. 2065 del 28/1/2011), come quella amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. Ad. Plen., sentenza n. 18 del 5 giugno 2012; VI Sez. n. 3513 del 10/6/2011), hanno avuto modo di fornire la qualificazione giuridica del decreto decisorio del Capo dello Stato assumendolo quale provvedimento assimilabile alle statuizioni esecutive del giudice amministrativo ex art. 112, comma 2, lett. b) c.p.a. Non solo, ma l’interpretazione giurisprudenziale ha altresì annotato che il ricorso per ottemperanza potesse legittimamente proporsi, in linea con le prescrizioni contenute nell’art. 113 c.1 c.p.a., dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, ovvero il “giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si tratta“.
Del resto, tale espansione del meccanismo tutorio ha trovato presidio nella serrata evoluzione dell’istituto, generata in primis dall’art. 69 l. 18 giugno 2009, n. 69, che introdusse l’incidente di costituzionalità e, insieme, abolì il potere del Ministero di scostarsi dal relativo parere. Quindi, dall’art. 112 dell’allegato 1 d.lg. 2 luglio 2010, n. 104 che, alla lettera b), previde l’azione di ottemperanza per le sentenze esecutive e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo. Nell’alveo di tale espressione, “altri”, trovò posto il decreto decisorio del Capo dello Stato, per l’effetto divenuto res judicata a tutti gli effetti.
L’esito è che la decisione resa su ricorso straordinario, pur non formalmente giurisdizionale, è tuttavia idoneo alla tutela mediante giudizio di ottemperanza (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 2065 del 28 gennaio 2011) e proietta, pertanto, una obbligazione conformatoria in capo alla P.A.
Si ricorda, ancora, che la novella dovuta all’art. 69 della l.18 giugno 2009, n. 69 ebbe, per un verso, a qualificare il parere reso dal Consiglio di Stato come assolutamente vincolante, per altro verso a determinare l’abrogazione della norma che consentiva al Governo scostarsi dal parere del Consiglio di Stato, mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri. Ciò che, in altri termini, ha potenziato il percorso di “giurisdizionalizzazione” del ricorso straordinario (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sentenza n. 82 del 25 gennaio 2010) e ne ha evidenziato il rango di titolo esecutivo.
***
Peraltro, tale livello di giurisdizionalizzazione della decisione straordinaria la si deduce dal successivo art. 15, a mente del quale I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall’art. 395 del codice di procedura civile.
Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 del codice di procedura civile il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti particolari delle singole amministrazioni; negli altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.
Al ricorso per revocazione sono applicabili le norme contenute nel presente capo.
Secondo i principi generali, la revocazione presuppone, necessariamente, un provvedimento giurisdizionale definitivo e passato in giudicato. La previsione di un meccanismo revocatorio anche per le decisione del Capo dello Stato ne certifica, in altri termini, la sostanza giurisdizionale e l’attitudine a fornire una risposta coattiva al relativo contenzioso.
VII – Limiti alla piena giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario.
Si è visto che il ricorso straordinario costituisce un indubbio ibrido concettuale, diviso tra la dimensione del rimedio amministrativo e quella, più stringente, del rimedio giurisdizionale, da cui ripete strumenti, valori, effetti suoi propri. Tuttavia, tale processo di assimilazione non è immune da limiti, imposti dalla necessaria unitarietà e coerenza dello strumento giurisdizionale. Il tema della alternatività, in particolare, pone severe questioni in relazione all’ipotesi di contemporanea pendenza, a fronte di plurimi provvedimenti connessi, di un procedimento giurisdizionale innanzi al Tar/Consiglio di Stato e di un procedimento straordinario innanzi al Capo dello Stato.
Su tale fronte, la Prima Sezione del Consiglio di Stato, con parere n. 2861 del 23.10.2019, ha avuto modo di fornire una lettura sistematica della materia, concludendo che, data la connessione ed interdipendenza tra due provvedimenti successivi, non sia ammissibile impugnare il secondo al di fuori del contesto giurisdizionale già incardinato per il primo. Ciò alla luce della chiarezza semantica dell’art. 8, secondo comma, del D.P.R. n. 1199 del 1971, a mente del quale non è ammesso il ricorso straordinario “da parte dello stesso interessato” se “l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale”. In definitiva, non è data doppia impugnazione in sedi differenti, pena l’improcedibilità della seconda.
La ratio di questo principio va colta in un’ottica sia formale che sostanziale. Essa, in altri termini, risponde così all’esigenza di semplificazione decisionale, come allo scopo di evitare il sovrapporsi di due differenti giudizi per medesima causale, con rischio di contrasti tra le decisioni del Consiglio di Stato in sede consultiva e le sentenze del Consiglio di Stato o del Tar in sede giurisdizionale. Senza dire che la duplicazione dei percorsi decisionali si risolve in una sostanziale vanificazione del giudice naturale precostituito per legge.
Tuttavia, la soluzione proposta dalla giurisprudenza non è di facile accordo alla molteplicità casistica. Si pensi all’ipotesi di una graduatoria generale che venga, magari in relazione a sopravvenienze giudiziarie, ad essere modificata e/o integrata. In questi casi, la seconda graduatoria dovrebbe essere a sua volta impugnata con ricorso per motivi aggiunti, nel solco del medesimo giudizio pendente e, dunque, nel termine di 60 giorni.
Quid juris se ciò non venga fatto e sussistano tuttavia i presupposti temporali per il ricorso innanzi al Presidente della Repubblica? E’ possibile immaginare una conseguenza definitivamente caducatoria, pur essendo giacente il termine di impugnazione straordinario?
Ebbene, seguendo con rigore il principio di alternatività, il richiamato parere il Consiglio di Stato ha ritenuto impraticabile la contemporanea pendenza di un ricorso straordinario e di un ricorso al giudice amministrativo quando, pur essendo diversi gli atti impugnati, la questione sia la stessa. Nella medesima ottica si è posta la giurisprudenza di merito (Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185; Cons. St., sez. II, 1 ottobre 2013, n. 4489; Cons. Stato, sez. I, 16 dicembre 2015, n. 211; Cons. Stato, sez. I, 6 marzo 2019, n. 866), che ha proclamato la doppia inammissibilità, sia del ricorso principale, non integrato da motivi aggiunti, sia del ricorso straordinario, incapace di vita propria in assenza di giudizio presupposto.
IX – Piena giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario ed estenzione della trasposizione nel processo amministrativo
Tuttavia, tale soluzione non convince. Ed invero, seguendo una simile lettura, si avrebbe il seguente esito: a) risulterebbe inammissibile l’impugnazione dell’atto conseguente o connesso innanzi al Capo dello Stato, nella giacenza del giudizio amministrativo avverso l’atto antecedente; b) risulterebbe improcedibile anche il primo ricorso giurisdizionale, stante la mancata impugnazione del secondo provvedimento connesso; c) si disperderebbe definitivamente il diritto alla tutela dell’interesse legittimo/diritto soggettivo dedotto, non potendosi provvedere alla riunione tecnica dei due giudizi.
Come uscirne?
Occorre considerare che il giudizio amministrativo ha assunto, nel tempo, i tratti della effettività e dello scrutinio non solo sull’atto ma anche sul rapporto. In questa ottica, si ricorda che il giudizio amministrativo deve essere “volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata” (Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2011, n. 3) poiché “la verifica di legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma è finalizzata all’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere, ritualmente, dalla parte attrice” (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4). Ciò, in applicazione dell’art. 1 c.p.a. che, per l’appunto, richiama ad un criterio di effettività del decisum e lo riconduce alla necessità di non delibare l’atto nella sua astrattezza, ma nella sua concretezza ed in quanto fonte di regolazione del rapporto.
In definitiva, allo scopo di salvaguardare il doppio binario decisorio, occorre andare oltre il principio di trasposizione previsto dall’art. 10 dpr 1199/71 per le sole parti controinteressate e gli enti pubblici differenti dallo Stato e fornire al ricorrente uno strumento che consenta, in ipotesi di atti connessi e/o interdipendenti, il travaso del secondo giudizio nel primo, superando così il vincolo di alternatività fissato dall’art. 8 dpr 1199/71. Ciò muovendo da un dato ineccepibile, ovvero il differente cronoprogramma dei due giudizi, l’uno presidiato da un termine decadenziale di 60 giorni, l’altro da un termine decadenziale di 120 giorni.
Posto dunque che la soluzione ottimale sarebbe certamente quella di investire delle due questioni un unico giudice, rimane il tema della natura bifasica della tutela, veicolata da termini di impugnazione differenti. E’ certamente rilevante l’obiezione che, per escludere l’eventualità di un doppio giudizio e, dunque, di un frazionamento della tutela, evoca il principio del giusto processo (art. 111 Cost.), anche nell’ottica dell’economia dei mezzi giuridici e per scongiurare il rischio di decisioni contrastanti, con conseguente lesione del principio dell’effettività della protezione giurisdizionale ai sensi dell’art. 24 Cost. e dell’art. 1 c.p.a. (C.S., I, 13.2.2019 n. 548). Tuttavia, non si può non considerare, in un’ottica di sistema, l’evoluzione in senso giurisdizionalistico del ricorso straordinario al Capo dello Stato, di tale statura da meritare, addirittura, il rango di fattore dell’incidente di costituzionalità. Ebbene, in questo quadro vasto è possibile risolvere alcune singolarità, ad esempio l’eventualità che, tempestivamente prodotto un giudizio amministrativo, non si sia avuto modo (per qualunque ragione) di impugnare per motivi aggiunti, innanzi al giudice amministrativo, l’atto connesso e si sia ricorso, dunque, alla impugnazione innanzi al Capo dello Stato. In questi casi si registrerebbe, pur a fronte di una tempestiva impugnazione dell’atto aggiunto, una sostanziale negazione di giustizia, estesa così al giudizio amministrativo, come a quello straordinario, pur nel contemporaneo rispetto dei termini di rispettiva impugnazione.
Nella realtà, si reputa che la tutela della parte vada, per quanto possibile, preservata.
De jure condito, la soluzione impone un’interpretazione evolutiva, che muova dall’interesse manifestato dalla parte ricorrente e dalla modalità temporale del secondo ricorso. Pertanto, se certamente si pone un tema di inammissibilità della seconda procedura straordinaria, se attivata all’interno del limite decadenziale dei 60 giorni, non altrettanto può dirsi allorchè la notifica del ricorso straordinario avvenga oltre il termine di sessanta giorni e prima, ovviamente, del 120° giorno. In quest’ultimo caso, immaginare una improcedibilità del secondo giudizio e, per trascinamento, anche del primo, appare una forzatura formalistica, avulsa dal principio del giusto processo e, piuttosto, esposta ai rischi del criterio “summum jus summa iniuria”.
Del resto, non registrandosi una preclusione espressa, nemmeno parrebbe equo imporre una conseguenza caducatoria a chi abbia avuto cura di accedere al ricorso straordinario nel segmento 60-120 giorni. Si genererebbe un triplo vulnus: a) per un verso verrebbe dichiarato improcedibile il secondo giudizio, in quanto violativo del principio di alternatività; b) per altro verso verrebbe dichiarato improcedibile anche il primo giudizio, in quanto non più autosufficiente alla luce della sopravvenienza del secondo provvedimento, avente medesima natura e conforme identità; c) infine, verrebbe negato integralmente e definitivamente il titolo giustiziale alla parte, ancorchè fortemente attiva nel censurare gli atti della P.A.
Soluzioni e conclusioni
E’ evidente che il caso merita una riflessione ‘funditus’ in quanto, in mancanza di una chiara regolamentazione, rischiano il gorgo delle inammissibilità entrambi i procedimenti.
De jure condendo, dunque, la soluzione dovrebbe trovare posto in un riordino del DPR 1199/1971 che, muovendo dalla compiuta giurisdizionalizzazione del procedimento straordinario, dovrebbe estendere l’istituto della trasposizione, previsto oggi per i controinteressati e gli enti pubblici chiamati (art. 10 DPR 1199/71), anche al ricorso straordinario incardinato con riferimento all’atto successivo e connesso. Ciò consentirebbe di rimediare alla mancata proposizione di motivi aggiunti in seno al primo processo amministrativo, valorizzando invece quella operata in seno al ricorso straordinario. In questo senso, l’integrazione del testo di legge dovrebbe finalizzarsi: a) a legittimare l’impugnazione innanzi al Capo dello Stato del secondo provvedimento, purchè dopo il limite di sessanta giorni ed entro quello di centoventi; b) a consentire la remissione del secondo giudizio innanzi al giudice del primo, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
In mancanza di un intervento riformatore, non resterebbe che il giudizio di costituzionalità, da porsi nei confronti del DPR 1199/1971, nella parte in cui non prevede l’ammissibilità del ricorso straordinario avverso il provvedimento successivo a quello già impugnato innanzi all’autorità giudiziaria, nonché la conseguente riunione del giudizio straordinario, facente luogo di quello per motivi aggiunti, a quello giurisdizionale.
Si ricorda che, sul piano concettuale, il ricorso per motivi aggiunti altro non è che un nuovo ricorso, ospitato per ragioni di connessione e semplificazione in seno al primo, ma da questo del tutto autonomo ed indipendente, al punto da poter prevedere uno scrutinio differente, separato o, addirittura, antinomico (v. C.S., VI, n. 6728/2024). Si ricorda, a conferma di quanto sopra, che il ricorso per motivi aggiunti assolve, per intero, il contributo unificato, segno di una indipendenza formale e sostanziale del relativo giudizio.
Per concludere, si reputa che le relazioni tra giudizio straordinario e rito giurisdizionale ordinario vadano ancora ampiamente esplorate e che, a tutela di diritti ed interessi legittimamente coltivati (artt. 24 e 113 Cost.), esse vadano colte in ottica conservativa, capace di ampliare e non comprimere le tutele spettanti e, per questa via, facilitare la protezione del ricorrente rispetto al fenomeno invalso degli atti consecutivi cui l’Amministrazione Pubblica, soprattutto in materia concorsuale, è ampiamente adusa.